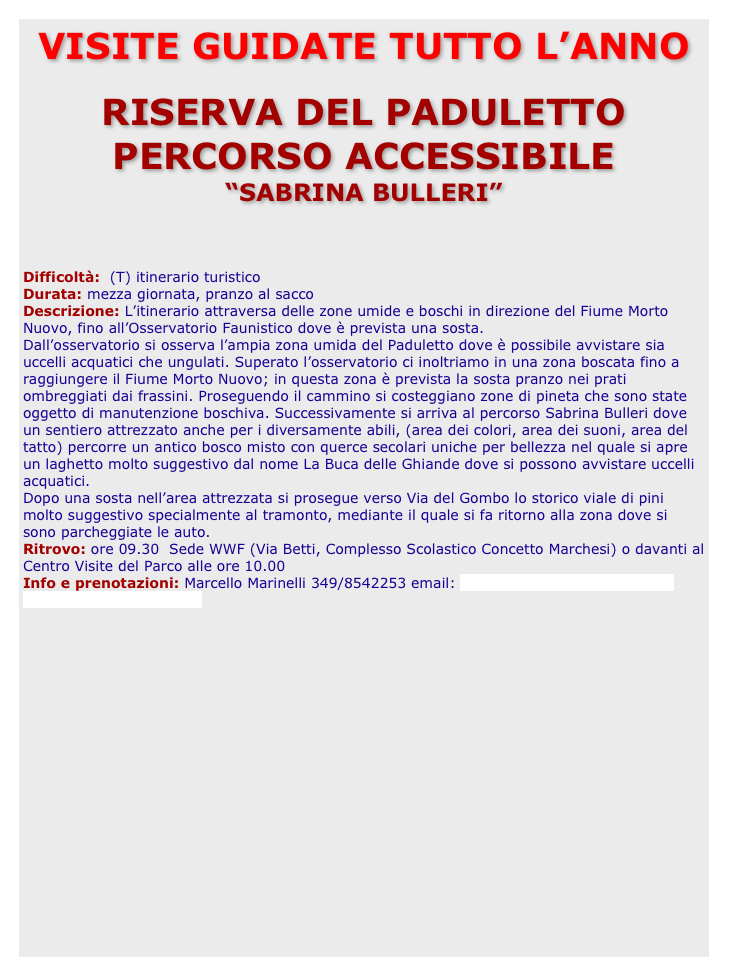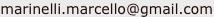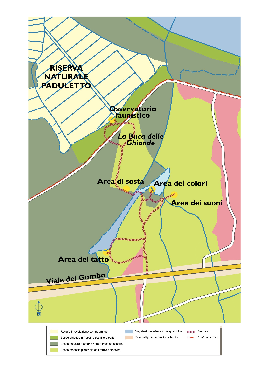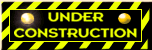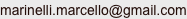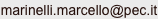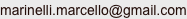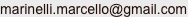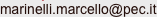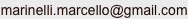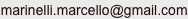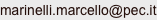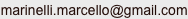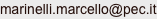“Troverai più nei boschi che nei libri. Gli alberi e le rocce ti insegneranno cose che nessun maestro ti dirà.”
(San Bernardo di Chiaravalle)
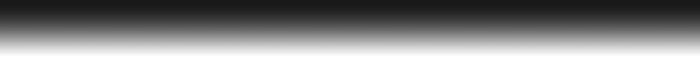



“Troverai più nei boschi che nei libri. Gli alberi e le rocce ti insegneranno cose che nessun maestro ti dirà.”
(San Bernardo di Chiaravalle)

La Tenuta di San Rossore è il cuore del grande Parco Regionale che - istituito nel 1979 - copre la fascia costiera da Viareggio a Livorno.
La tenuta si estende per 4.800 ettari e possiede una flora variegata che, in boschi di farnie, pioppi, frassini, ontani e pini, ospita anche rarità vegetali come la Periploca graeca e la Drosera rotundifolia. Anche la fauna è ricca: la macchia è popolata da cinghiali, daini, volpi e altri piccoli mammiferi, oltre a circa duecento varietà di uccelli, tra cui il Cavaliere d’Italia. Nella tenuta è attivo un importante ippodromo per corse al galoppo e, in località Le Sterpaie, dal recupero di edifici esistenti, è stato ricavato un centro di accoglienza e di residenza turistica destinato ad ampliarsi. Un’ampia strada attraversa la macchia e conduce al Gombo, sulle rive del Tirreno, ove Byron fece cremare il cadavere dell’amico Shelley, ivi morto il 7 luglio 1822.
La tenuta fu via via proprietà della Mensa Arcivescovile, dei Medici, dei Savoia, della Presidenza della Repubblica: oggi appartiene alla Regione Toscana.
La Tenuta di San Rossore è racchiusa fra il fiume Serchio a nord, l'Arno a sud e il Mar Tirreno a ovest. Comprende aree boschive, agricole, ad est dei boschi, e la ex tenuta presidenziale, ora di proprietà della Regione.
La morfologia del territorio è caratterizzata dall’alternarsi di dune, i "cotoni" o tomboli, alti anche più di 10 metri e da zone depresse, interdunali, in parte periodicamente allagate, le "lame". Una formazione che è datata più di 4000 anni fa e generatasi a seguito della deposizione di materiale sabbioso di provenienza marina e fluviale (depositi alluvionali dei fiumi Arno e Serchio). L’assetto attuale della Tenuta non corrisponde sicuramente a quello originale, bisogna considerare i numerosi interventi umani. Fino al II secolo a.C., il fiume Serchio formava un lago nella pianura della città di Lucca, per poi sboccare direttamente nel fiume Arno; quest’ultimo formava a sua volta un ampio sistema deltizio e lagunare. I Romani denominarono la zona che si estendeva tra i monti Livornesi e Filettole "Selva Palatina".
Già nel IX secolo d.c. il vescovo San Fedriano, dietro richiesta dei lucchesi, e allo scopo di bonificare la piana di Lucca, intraprese l’opera di deviazione del fiume Serchio, spostandone il corso più a nord e portandolo a sfociare direttamente in mare all’altezza di Migliarino (Pi). Nel 1600 fu operato il "Taglio Ferdinandeo" sotto la direzione di Ferdinando II dei Medici, spostamento della foce dell’Arno verso nord per impedire eventuali insabbiamenti del porto di Livorno. Nel 1732 i Lorena, succeduti ai Medici nel governo del Granducato, per rispondere alla crescente necessità di legname da costruzione, iniziarono una incisiva azione di riforestazione.
In quest'epoca si afferma la coltivazione delle pinete da pinoli sui tomboli che assumerà sempre maggiore importanza economica, almeno fino all'odierno dopo guerra. Iniziò inoltre il riassetto idraulico complessivo della Tenuta attraverso una intensa opera di bonifica" per colmata. Successivamente la Tenuta passò alla Corona d’Italia, e infine, con la proclamazione della Repubblica Italiana, San Rossore è passata alla Presidenza della Repubblica. Dalla fine del 1996 la gestione è di competenza della Regione Toscana, che nel maggio 2000 l’ha passata all'Ente Parco Regionale di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli.
Il risultato di queste numerose trasformazioni, ad opera della natura e dell’uomo, è un paesaggio fondamentalmente caratterizato da zone asciutte, dove troviamo le classiche pinete, piantate a scopo protettivo (delle retrostanti colture agricole) e produttivo (pinoli e legno), quasi sempre associate al leccio (specie autoctona), e da zone umide, le "lame", dove sono rimasti boschi planiziali originari a latifoglie che caratterizzano anche l’area che il nostro itinerario attraversa.







web designer: Marcello Marinelli